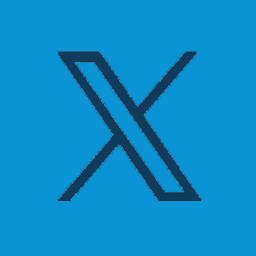
Il paradosso dell’Ue: per difesa europea serve un’azione non comunitaria
Il paradosso dell’Ue: per difesa europea serve un’azione non comunitariaRoma, 22 feb. (askanews) – Nella politica estera l’Ue è debole e divisa, anzi: è debole perché è divisa. Agisce su mandato degli Stati membri, ma questo mandato deve essere unanime, e basta che un solo paese non sia d’accordo con la stragrande maggioranza degli altri, per paralizzare qualunque decisione.
Basta vedere il ritardo, l’inconcludenza, o addirittura l’assenza delle reazioni dell’Europa alle minacce, le provocazioni e gli attacchi di Donald Trump. La Commissione europea è ben attrezzata per le risposte alle ‘aggressioni’ americane nel settore del Commercio internazionale, perché ha competenza esclusiva in quest’area; ma non è così per la politica estera e per la difesa, dove il potere è tutto nelle mani degli Stati membri, e l’Ue in quanto tale appare solo timidamente, pateticamente, cercando sempre faticosamente di avere una posizione senza inciampare nel veto di questo o quel paese. Perché possa esistere, con un peso politico significativo sulla scena mondiale, con una sua politica estera e di sicurezza e con una vera e propria politica industriale comune per la difesa, l’Europa dovrà agire al di fuori dell’Ue e delle politiche comunitarie, con accordi intergovernativi tra gli Stati membri dell’Unione disposti ad avanzare su questa strada e con altri paesi europei extracomunitari, come il Regno Unito e la Norvegia.
E’ questo, tra l’altro, il senso più probabile dei due mini summit successivi che il presidente francese, Emmanuel Macron, ha organizzato con diversi capi di governo europei, ma comunque senza invitare i paesi più filo russi. La cosa più importante ora è capire se ci sia la volontà da parte dei paesi presenti all’Eliseo di far partire una nuova Europa della difesa, con il Regno Unito e magari la Norvegia e senza le palle al piede di Ungheria e Repubblica ceca o di altri paesi dell’Est che non sono pronti. Si potrebbe addirittura pensare a un nuovo trattato che decida l’esercito europeo, uno stato maggiore europeo, decisioni a maggioranza qualificata con la possibilità per chi non è d’accordo di tirarsi fuori senza bloccare gli altri, e soprattutto una vera politica industriale europea centralizzata e armonizzata, almeno per il settore della difesa. C’è anche la strada, prevista dai Trattati Ue, delle ‘cooperazioni rafforzate’: un certo numero di Stati membri che si mette d’accordo per andare avanti verso un obiettivo condiviso senza aspettare gli altri, ma pronto ad accoglierli se decidono di raggiungerli; un gruppo, quindi, da cui sono esclusi fin dall’inizio i paesi reticenti, che non possono quindi usare il diritto di veto contro il progetto comune. Come ricorda un veterano delle istituzioni Ue, Emilio De Capitani, ex funzionario del Parlamento europeo, ‘è già avvenuto con l’accordo di Schengen per la soppressione dei controlli alle frontiere interne, con gli accordi di Prum per la cooperazione di polizia contro il crimine organizzato, e con l’accordo sul Mes’ per i prestiti agli Stati membri con problemi di bilancio. ‘Queste forme di cooperazione ‘parallela’ all’Ue, ma che ne anticipano gli obiettivi – ci ha detto ancora De Capitani – sono state considerate legittime persino dalla Corte europea di Giustizia (giurisprudenza ‘Pringle’)’.
Con questo in mente, vale la pena di rileggere ciò che ha detto Mario Draghi nel suo ultimo intervento al Parlamento europeo, il 18 febbraio a Bruxelles, parlando della necessità di cambiare il modello decisionale dell’Ue: ‘Una cosa che dobbiamo prima considerare è: l’unanimità continuerà a essere il principio guida chiave per prendere decisioni nella nostra Unione?’ Il rapporto sulla competitività da lui presentato, ha ricordato l’ex premier italiano, ‘suggerisce che, in effetti, non dovrebbe esserlo, che dovremmo passare a una maggioranza qualificata su molte, molte aree. E la mia sensazione è che, nei prossimi mesi, i paesi si raggrupperanno esattamente su questo punto, paesi che continueranno a difendere l’unanimità e paesi che sono pronti a scendere a compromessi e ad andare verso un meccanismo di voto a maggioranza qualificata’. ‘Ma poi – ha continuato Draghi – il rapporto dice che ci sono anche altri modi. Uno è il modello di cooperazione rafforzata, che è presente nei nostri Trattati, ma non siamo creativi su questo. E il terzo è, francamente, il modello intergovernativo: vale a dire due, tre, quattro governi che concordano su certi obiettivi e decidono che si muoveranno insieme, rimanendo aperti all’ingresso di altri paesi’. ‘Io penso, spero, che sia ovviamente meglio andare tutti insieme; ma per andare insieme, specialmente in settori come la difesa, la politica estera, c’è bisogno di una valutazione comune di quali sono i rischi, e quali sono i compromessi, o soprattutto di chi è il nemico. Bisogna essere tutti uniti su questo’, ha concluso l’ex presidente della Bce. Finora, il problema che ha diviso gli europei è quello del finanziamento della spesa per gli investimenti nelle capacità di difesa, come e dove trovare le ingenti risorse necessarie (nuovo debito nazionale o europeo, o tagli ad altre voci della spesa pubblica), e come considerarle nel quadro delle regole Ue sui bilanci del Patto di stabilità riformato (su questo punto la Commissione europea ha già annunciato la sua sospensione per la spesa militare). Un rapporto appena pubblicato dal think-tank Bruegel (‘Defending Europe without the US: first estimates of what is needed’, di Alexandr Burilkov e Guntram B. Wolff, 21 febbraio 2025) conclude che, per prendere interamente a suo carico la propria difesa, l’Europa avrebbe bisogno di un numero ingente di nuove truppe da mobilitare (300.000 soldati) e di un aumento di almeno 250 miliardi di euro all’anno della sua attuale spesa militare, che è oggi al 2% del Pil, in media, ma che dovrebbe raggiungere il 3,5%, come sta già cominciando a chiedere la Nato.
Ma ora, oltre al problema dei finanziamenti, dopo le clamorose posizioni assunte dalla nuova Amministrazione Trump, che non lasciano dubbi sulle intenzioni di ritirare gran parte delle forze Usa dal dispositivo Nato di difesa dell’Europa, la discussione si sta spostando su un altro piano: come spendere e come utilizzare queste nuove risorse, in base a quali piani, coordinati, centralizzati e decisi da chi, in base a quale politica industriale. Che cosa significa una politica industriale europea per la difesa? Sostanzialmente significa che gli Stati partecipanti devono conferire a una struttura centralizzata una serie di poteri che vanno ben al di là del coordinamento, dello ‘stimolo’, della fissazione di obiettivi indicativi, dei contributi finanziari. Una politica industriale unica della difesa significa che questo potere centralizzato potrebbe imporre all’apparato industriale di ciascun paese partecipante, degli appalti congiunti di fornitura, che cosa produrre, con quali caratteristiche, in quali quantità, a quali prezzi, a chi vendere e da chi comprare, e secondo quali quote, ed eventualmente le capacità aggiuntive da installare oppure, al contrario, le sovracapacità o le capacità superflue da eliminare. Tutto questo oggi, con l’attuale quadro giuridico Ue, non è possibile. Il Trattato sul funzionamento dell’Unione non comprende la politica industriale tra le ‘competenze condivise’ (art.4), per le quali gli Stati membri possono agire solo se l’Unione ha scelto di non esercitare la sua competenza (ad esempio nelle politiche dei trasporti, della coesione, dell’energia e dell’ambiente e del mercato interno). L’industria, invece, è tra le competenze nazionali (art.6), come la cultura e il turismo, per le quali l’Ue può sostenere, coordinare o completare le azioni degli Stati membri, ma non può adottare atti giuridici vincolanti che richiedano loro un’armonizzazione europea delle proprie leggi e dei propri regolamenti. Un vero e proprio piano di politica industriale europeo, in realtà, è stato realizzato una sola volta, nel periodo 1977-1982, nel settore siderurgico, su iniziativa della Commissione e in particolare di Etienne Davignon, allora responsabile per gli Affari industriali e il Mercato interno. Il commissario Davignon ottenne una dichiarazione ufficiale di ‘crisi manifesta’ nel settore siderurgico, votata dai governi dell’allora Comunità europea, in base a cui la Commissione fu autorizzata ad adottare ampie misure contro la sovracapacità, come la regolamentazione dei prezzi (prezzi minimi), quote di produzione obbligatorie, soppressione di capacità, come condizione per il sostegno comunitario ai piani di ristrutturazione nazionali, e poi regolamenti contro i sussidi statali, quote per le importazioni da paesi terzi. Ma tutto ciò sarebbe impossibile oggi, perché la base giuridica del piano Davignon era il Trattato di Parigi del 1951 sulla Comunità europea del carbone e dell’acciaio, che è scaduto nel 2002. E’ vero che esiste una Agenzia europea per la difesa (Eda), istituita come una ‘azione comune’ dal Consiglio Ue nel 2004, poi integrata nel sistema istituzionale col Trattato Ue di Lisbona (art. 42) e ulteriormente sviluppata con ulteriori decisioni del Consiglio Ue nel 2011 e nel 2015 che ne hanno definito lo statuto, la sede (a Bruxelles) e le norme operative. Ma se si guarda ai compiti dell’Agenzia, si capisce subito che non sarebbero sufficienti a realizzare una vera propria politica industriale europea nel settore. Le sue tre missioni principali sono ‘sostenere lo sviluppo delle capacità di difesa e la cooperazione militare tra gli Stati membri dell’Unione europea; stimolare la ricerca e tecnologia e rafforzare l’industria europea del settore; agire come interfaccia militare per le politiche dell’Ue’. Sul sito dell’Eda, si legge inoltre che l’Agenzia ‘funge da catalizzatore, promuove collaborazioni, lancia nuove iniziative e introduce soluzioni per migliorare le capacità di difesa. È il luogo in cui gli Stati membri che desiderano sviluppare capacità in cooperazione lo fanno. È anche un facilitatore chiave nello sviluppo delle capacità necessarie a sostenere la politica di sicurezza e difesa comune dell’Unione’. Tutto qui. E si sa che non sono stati un grande successo finora i tentativi di acquisti con appalti in comune, come quelli sperimentati per i vaccini e per l’energia, mentre si continua a deprecare lo spreco dei ‘doppioni’ e della mancanza di complementarietà tra le diverse capacità produttive delle industrie nazionali della difesa (ad esempio con decine di modelli di carri armati, mentre gli Usa ne hanno uno solo) e dagli alti costi di produzione dovuti alla mancanza della dimensione di scala europea. Per non parlare delle lacune enormi che il disimpegno Usa lascerebbe, in particolare, nella copertura satellitare e nella difesa aerea. Di Lorenzo Consoli e Alberto Ferrarese